La lontananza dei paesi compensa in qualche modo l’eccessiva prossimità dei tempi.
– Citazione da Racine in apertura del film
Sei Shonagon, dama di corte della principessa Sadako, aveva la mania delle liste. Aveva una “lista di cose eleganti”, una “lista delle cose desolanti”, una “lista delle cose che fanno infuriare”, una “lista di cose che non possono essere comparate”. Una “lista di cose sconcertanti”, una di “cose profondamente irritanti”, una di “cose che danno una sensazione di pulito”. Leggere i titoli delle liste di Sei Shangon è avvincente quasi più del loro contenuto.
Le mie liste non hanno certo lo spessore letterario e poetico di quelle di Sei Shonagon, rimangono rispettosamente fedeli ad un primario carattere ordinativo e prevengono qualunque possibilità di amnesia. Ho diverse liste a contenuto cinematografico: una di queste è la “lista dei film che mi riconnettono all’umanità”.
Uno dei film contenuti in questa lista è quello di cui parliamo oggi: Sans Soleil, del 1983, di Chris Marker.
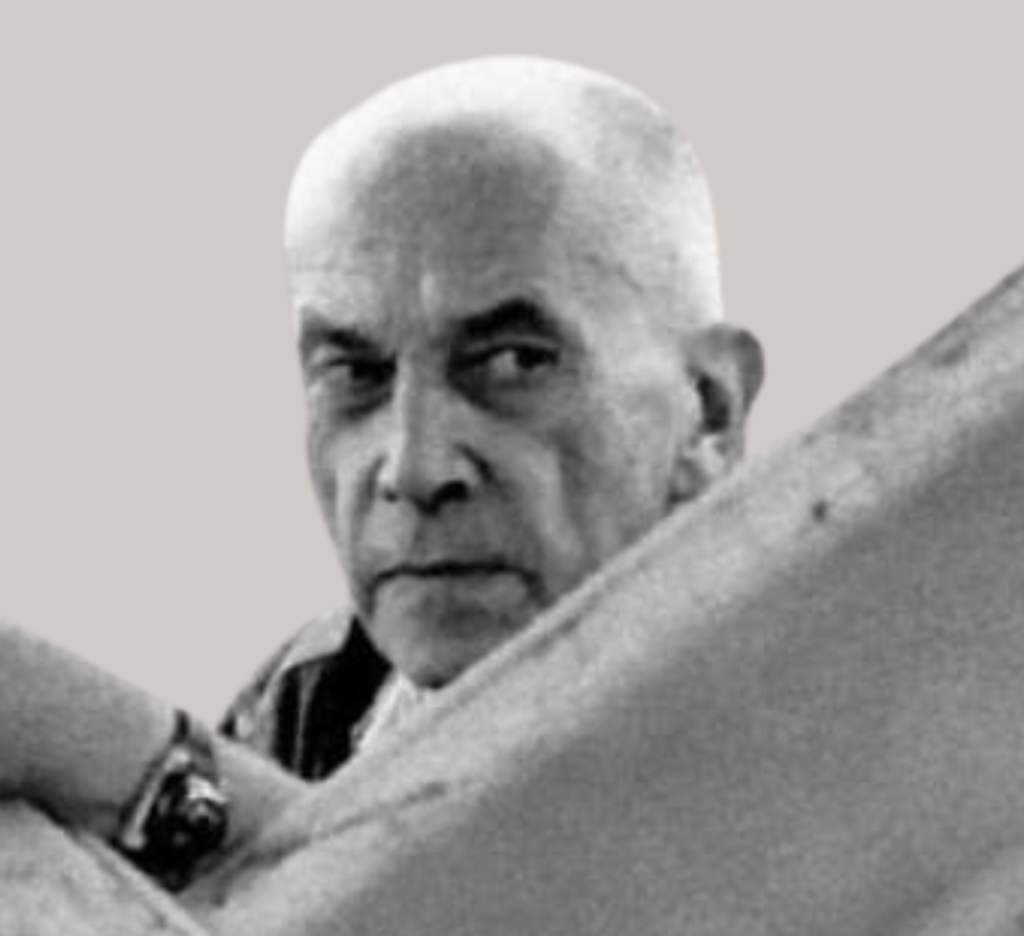
Chris Marker
Sans Soleil è un film la cui parte visiva è composta da frammenti di filmati girati negli anni (dal regista o da altri) in varie parti del mondo: molto a Tokyo, parte a Bissau, Capo Verde, l’Islanda che apre e chiude, come in un cerchio, questo racconto sul mondo. Ci sono ritratti di persone, le donne africane di Bissau, i tre bambini islandesi, la folla delle strade giapponesi; ritratti di animali, tra cui molti gatti, una giraffa che viene abbattuta, i cani sulla spiaggia dell’isola di Sal, gli emù. Ritratti di paesaggi e ritratti di oggetti. La panoramica sulle statuette di gatti del tempio giapponese Gotokuji l’avrete vista probabilmente in qualche documentario sulla storia del cinema.
Non c’è un ordine apparente nella maniera in cui questi frammenti vengono ricuciti tra loro dal lavoro di montaggio: è piuttosto una sequenza emotiva, metaforica, una sorta dell’equivalente cinematografico del flusso di coscienza delle opere letterarie. Mentre le immagini scorrono, una voce femminile racconta le lettere di qualcuno che descrive i suoi viaggi, i suoi pensieri, i suoi frammenti di vita quotidiana e le usanze e atmosfere dei luoghi che visita. Una scritta alla fine del film attribuisce queste lettere a Sandor Krasna, ma questo personaggio è fittizio: è l’occhio invisibile che guarda e registra e rielabora, dentro e fuori la storia, un alter ego di Marker.


La festa di quartiere e uno scorcio di folla a Tokyo – fotogrammi dal film
Voglio dirvi qualcosa di più su di lui. A discapito del nome anglofono, Chris Marker è francese, pseudonimo di Christian Bouche-Villenueve. Per intenderci, il regista di La Jetée del 1962. “Marker”, il suo pseudonimo inglese, è indicativo: significa pennarello, o evidenziatore, o segnavia, o indicatore.
Ed esattamente come un pennarello, Marker – alias Sandor Krasna – marca attraverso la voce della donna la connessione profonda tra un filmato e un altro, tra luoghi lontanissimi, tra pensieri che si intrecciano. “A proposito, sapevate che ci sono degli emù, nell’ Ile-de-France?”. Marker parla, racconta. Racconta i mercatini di Tokyo e la difficoltà di riprendere i volti delle donne di Bissau, racconta la storia della statua del cane Hachiko e il comportamento dei suoi cani sulla spiaggia dell’Isola di Sal mentre giocano con il mare. “Più tardi, ascoltando Radio Hong Kong, capii: quello era il primo giorno del nuovo anno lunare e per la prima volta in 60 anni il segno del Cane incontrava il segno dell’Acqua”.
Marker parla molto anche della morte, sia nella sua essenza che nelle forme dei riti che la accompagnano. Una delle prime riprese è quella che segue alla panoramica delle statuette di Gotokuji, al cimitero dei gatti dove una anziana coppia ha portato una tavoletta intagliata per pregare per la loro gatta Toro (“non era morta, solo scappata. Ma il giorno della morte nessuno avrebbe saputo come pregare per lei, come intercedere affinché la morte la chiamasse col suo vero nome. Dovevano venire qui insieme, sotto la pioggia, a celebrare un rito che avrebbe riparato, dove si sarebbe rotta, la ragnatela del tempo”). Più tardi, un altro funerale animale, nella commemorazione del panda dello zoo di Ueno. Subito dopo, il brutale abbattimento di una giraffa nella savana, richiamo immediato degli uccelli necrofagi. Marker evidenzia la differenza della percezione della morte. Per la filosofia asiatica, “la barriera che separa la vita e la morte non sembra così alta come per un occidentale”, mentre in altri paesi, nell’arcipelago delle Bijagos, “la morte non è una barriera da oltrepassare, ma una strada da seguire isola per isola, secondo un rigido protocollo”. Anche la lotta, la violenza mortifera e inevitabile dei guerriglieri viene riassunta semplicemente: “avevano lottato in condizioni talmente disumane da avere pietà per i portoghesi che avevano patito la stessa sofferenza”.

“Come si fa a ricordare la sete?” – fotogramma dal film
Marker racconta “l’impermanenza delle cose”, un mondo “di apparenze fugaci, revocabili”, a cui i giapponesi sono stati abituati da una “natura beffarda che è sempre pronta a sfilare” da sotto i loro piedi, a suon di terremoti, il tappeto terrestre su cui vivono, e gli africani della Guinea Bissau da governi e uomini che si rovesciano a vicenda senza sconti.
Racconta l’erotismo spettacolarizzato, dove “la censura non è mutilazione dello spettacolo, è lo spettacolo stesso” e quell’abitudine tutta umana di nascondere e coprire di veli (“come fanno le religioni”) cose che nella natura sono aperte ed esplicite, ma sempre secondo dei propri criteri. Si può sfumare alla vista il pube di una ragazza in un “programma per adulti” e dedicare una mostra francese alla rappresentazione fallica (“il sesso è visibile solo se separato dal corpo”).
Racconta di Sei Shonagon, la dama di compagnia della principessa Sadako vissuta mille anni fa, con la lista delle “cose che fanno battere il cuore”.
Racconta il progetto di un film di fantascienza che si sarebbe dovuto chiamare “Sans Soleil”, dall’ultima opera di Mussorgsky, un film che – lo sa già – non sarà mai fatto. Ma racconta di come avrebbe voluto che si aprisse con il filmato di tre bambini islandesi, l’immagine della felicità seguita dal nero di un lungo stacco, come all’inizio del nostro Sans Soleil. Un film sulla memoria e sul significato incomprensibile del dolore, ambientato in un futuro perfetto e perfezionato. Racconta anche di Vertigo – La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock: mi sembra evidente che sia stato uno dei film amati dal regista. Anche in La Jetée c’era un riferimento al lavoro di Hitchcock, nella stessa scena di fronte ai cerchi di un albero e della breve vita nell’ultimo spazio prima del bordo.
Il lavoro di Chris Marker dovrebbe essere visto più di una volta. Dopo la prima, si notano le ricorrenze dei temi, delle immagini. Gli emù dell’Ile-de-France che compaiono all’inizio, in mezzo (fugace apparizione tra le immagini di una festa di quartiere di Tokyo) e di nuovo alla fine. I cani sull’isola di Sal, già presentati all’inizio. Volti e oggetti nelle loro mille variazioni. La struttura di Sans Soleil onora il proprio titolo e si comporta esattamente come una composizione musicale, dove le note si rincorrono dall’inizio. Mi sembra che calzi a pennello questa considerazione che presentava Bèla Balazs in un suo saggio degli anni Cinquanta (Il film: evoluzione ed essenza di un’arte nuova), a sua volta ritagliata da Bergson:
“La melodia è composta di singoli suoni che echeggiano successivamente nel tempo. Tuttavia, la melodia non si estende nel tempo, poiché il primo suono in tanto costituisce un elemento della melodia quanto prelude al prossimo ed è in rapporto con l’ultimo. L’ultimo suono, dunque, esiste già nel primo come parte della melodia, anche se il nostro orecchio lo percepirà qualche secondo più tardi. Inoltre: l’ultimo suono costituisce la nota finale della melodia, solo perchè in esso è ancora presente il primo. […] La linea unificatrice della melodia non si estende nel tempo. Il rapporto dei suoni fra loro non è un fenomeno temporale. […] Le stesse note, prese singolarmente, hanno una durata. Ma il rapporto tra l’una e l’altra non è temporale. Ed è proprio questo che dà un senso alle note.”
Sostituite note con “immagini”, melodia con “film”, suono con “scena”. La musica e il cinema, entrambe forme d’arte che hanno una espansione nel tempo, rispondono a questo modello descritto da Balazs. Sans Soleil, che ancora non esisteva al tempo in cui lo scrittore ungherese faceva le sue considerazioni, è esemplare sotto questo punto di vista.

La donna che prega per la gatta Toro – fotogramma dal film
Come accennavo, Sans Soleil è uno di quei film che mi riconnettono all’umanità. Forse perché di umano ce n’è molto, con volti e pensieri e azioni. Forse perché Sans Soleil è in qualche modo un viaggio filosofico, un diario che riporta a chi legge le stesse emozioni di chi ha scritto. Nel nostro mondo, dove quasi ogni viaggio è una vacanza o un business o qualcosa da fotografare per essere appeso alla bacheca virtuale dei nostri social network, Sans Soleil esercita su di me una forma di richiamo antichissimo, ancestrale: il bisogno completamente umano di vagabondare, osservare, ritagliare ricordi e pensieri, per creare sé stesso e riconoscersi parte di un tutto.
È proprio per questo motivo che questo film del 1983, rivisto a quarant’anni di distanza dal momento in cui è stato prodotto, mi sembra che possa mantenersi intatto nella sua contemporaneità. Nel 2083, quando questo film avrà cento anni, quante cose saranno cambiate. Eppure, quante, e Sans Soleil riesce a catturarne molte, si saranno confermate immutabili caratteri degli esseri umani come individui e come dinamica.
Penso alla gente che danza, ai dipendenti bistrattati che passano del tempo immaginando i propri superiori del lavoro al posto delle bestioline da martellare in un gioco di velocità, ai gatti sui tetti e nelle case, compagni fidati di uomini che dedicheranno a loro versioni dei propri riti funebri, e ai deserti del mondo, agli Etas dell’era Meji, “parola impronunciabile” che tuttavia esistono sempre, come sempre. Penso anche alla capacità di immedesimarsi, quella necessaria a comprendere “quello che Lèvy-Strauss chiamava ‘intensità delle cose’”. Non abbiamo bisogno di essere – di nascere – gatti o giapponesi, di vivere le guerre guineane o di affrontare il lungo tragitto nel traghetto che collega l’Hokkaido a Tokyo. Ma ci possiamo immedesimare. Guardando Sans Soleil, forse non diventiamo parte del Giappone o del carnevale di Bissau o della vita di un gatto, ma tutte queste cose, tutte queste fugaci apparizioni diventano parte di noi. Con noi, parte di un tutto.

L’uomo sul traghetto per Tokyo – fotogramma dal film
Personalmente, non so collocare questo film in un genere. È un documentario? È una lettura? È qualcosa di sperimentale che definisce un genere nuovo? Qualcuno lo ha definito documentario sperimentale, ma è proprio quel “documentario” che non mi convince appieno. Bazin, negli anni Cinquanta, lo definì un “film-saggio”. Chissà, dove andrebbe collocato. Forse Sei Shonagon avrebbe saputo darmi una mano. Forse dovrei aggiungere alle mie liste una “lista di film indefinibili”. Forse.






