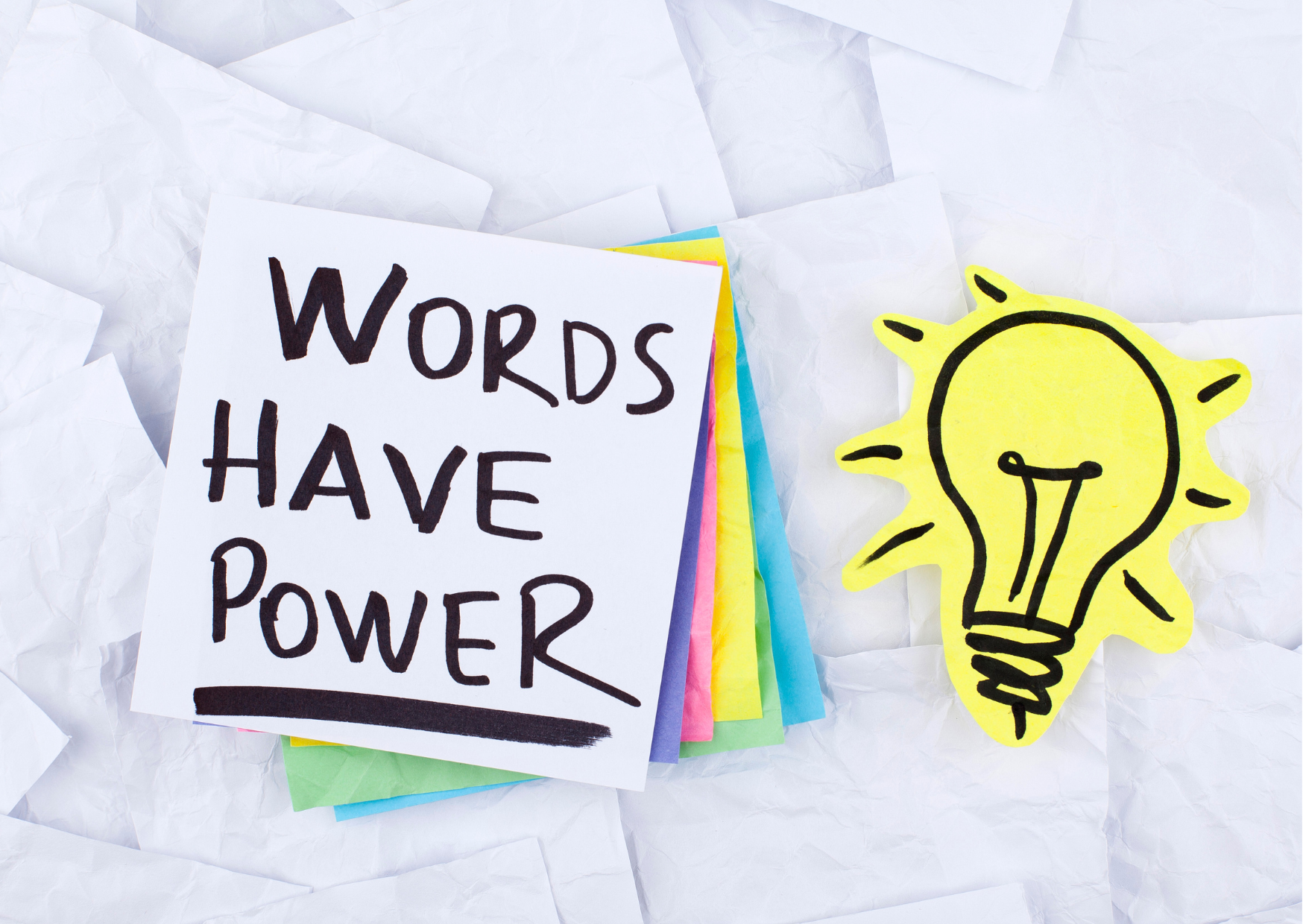Il lessico è il livello più visibile della lingua “e che muta più velocemente per rimanere aggiornato rispetto alla realtà e alla società che rispecchia. La lingua si adatta alle necessità dei suoi parlanti, e il lessico è in qualche modo la sua parte più mobile. Conoscere le parole ci aiuta a capire meglio il mondo, dato che le usiamo per concettualizzare la realtà e renderla raccontabile”.[1]
Questo articolo, non pretendendo di esporre in modo esauriente le regole della grammatica italiana, vuole analizzare alcuni aspetti linguistici e socio-culturali legali alla questione della declinazione femminile di alcune professioni, cercando di affrontare le obiezioni più frequenti.
“Quel nome al femminile vuol dire un’altra cosa”
Su un social, il post di un articolo sulla portiera Alice Pignagnoli – che ha denunciato di non ricevere più lo stipendio perché rimasta incinta – e sotto il commento: “portiere casomai, la portiera è un’altra cosa”.
Si chiama polisemia, in linguistica, la facoltà di alcune parole di avere significati diversi a seconda del contesto in cui vengono utilizzate: penna per scrivere, penna come piuma di un uccello; il termine fisico può indicare chi studia la fisica e allo stesso tempo la conformazione di un corpo umano. Ebbene, anche portiera è una parola polisemica…
<portière s. m. [dal fr. portier, che a sua volta è dal lat. mediev. portarius]. – 1. a. In genere, chi ha la custodia di una porta (di un edificio, di una città, ecc.). 2. (f. -a) In alcuni giochi a squadre con la palla o il disco (calcio, hockey, pallanuoto), il giocatore posto a guardia della porta con il compito di fermare la palla o il disco prima che superi la linea di porta, per evitare che la squadra avversaria segni punti a proprio favore>.
Quindi, la polisemia non è un motivo logico per non fare uso di termini femminili, perché così non potremmo utilizzare gran parte delle parole che conosciamo (il grafico, la politica, la chimica o la matematica). Il reale motivo è il pregiudizio che si cela dietro: le donne non possono praticare uno sport maschile e, se possono, il loro ruolo deve avere una declinazione maschile…
“Così si stravolge l’italiano!”
Basterebbe aprire un dizionario, se proprio non si vuole studiare la lingua italiana, eppure c’è sempre qualcosa che ostacola il pensiero che no, non si sta storpiando nulla, semplicemente si stanno applicando regole grammaticali.
In italiano abbiamo le seguenti classi nominali e aggettivali:
- I nomi di genere fisso: termini completamente diversi per indicare i due generi (fratello/sorella);
- I nomi di genere comune: ambigeneri, non sono marcati per genere (pediatra, giovane) ma hanno un genere grammaticale che appare nei termini di accordo (il giovane simpatico/la giovane simpatica, il pediatra/la pediatra);
- I nomi di genere promiscuo: hanno un’unica forma grammaticale, non ambigenere (guardia, vittima, pedone);
- I nomi di genere mobile: si declinano in base al genere, come maestro/maestra (o ministro/ministra), impiegato/impiegata (o avvocato/avvocata), infermiere/infermiera (o ingegnere/ingegnera)[2].
Questo breve elenco servirà di premessa per capire meglio quanto siano pretestuose le obiezioni che più sentiamo in relazione alla declinazione femminile delle professioni.

“Ma allora se diciamo ministra e avvocata diciamo anche il giornalisto e il pediatro…”
Alcuni commenti, che leggiamo spesso, sono – assolutamente seri e non ironici – “ma allora se diciamo ministra e avvocata diciamo anche il giornalisto” (che anche word si rifiuta di accettare durante la stesura di questo articolo). Ora, è chiaro che sussiste un grave problema di ignoranza riguardo la lingua italiana: giornalista, penalista, pediatra sono, appunto, ambigeneri, ciò significa che sono epiceni ed è l’articolo a declinare il genere: il pediatra, la pediatra. Sono ambigeneri i nomi che derivano da un participio presente come studente o presidente (lo studente/la studente, il presidente/la presidente) o alcuni tipi di nomi in -e, come vigile o preside (il vigile/la vigile, il preside/la preside).
“È cacofonico”
La lingua italiana si presta facilmente per declinare al femminile qualsiasi nome. I termini che suonano male non contrastano con la lingua italiana, ma con stereotipi culturali che interiorizziamo e non sempre riconosciamo. Basta fermarsi a riflettere su nomi che suonano allo stesso modo e che non abbiamo difficoltà a pronunciare.
Architetta, avvocata, ministra, ingegnera “suonano male”. Perché avvocata, che suona come impiegata, suona male? (impiegata, pregiudicata, avvocata sono tutti participi passati). E perché architetta, che suona come perfetta o protetta, suona male? O, ancora, ingegnera, che suona come infermiera?
Suona male ciò che non siamo abituati a sentire, suona male ciò che contrasta con gli stereotipi culturali. Perché se si vede una donna che ha la cura di un palazzo, viene chiamata tranquillamente portiera, mentre una donna calciatrice, portiere? Il motivo di tale ostilità è che il genere femminile, nei nomi che fanno riferimento a ruoli di prestigio o ruoli assegnati al genere maschile – e non di cura – contrasta con stereotipi culturali che non sempre sono facili da riconoscere.
A questo punto, il processo di negativizzazione della lingua italiana avviene in due modi: si aggiunge il suffisso derivazionale -essa (giudicessa, poetessa, studentessa), oppure il maschile vale per entrambi i generi (come se un impiegato uomo lo chiamassimo impiegata).
Il suffisso -essa
Sarebbe corretto, sempre nell’utopia della conoscenza della lingua italiana, evitare il suffisso -essa (attenzione, non esiste una controparte simmetrica che faccia derivare il maschile dal femminile, non esiste alcun professoresso). Il suffisso -essa non è corretto per declinare un nome al femminile, in quanto nasce principalmente per indicare le “mogli di” (la presidentessa, moglie del presidente).
La lingua italiana ci consente tranquillamente di poter declinare al femminile i termini, senza dover stravolgere ciò che è già in uso. Alcuni esempi:
- giudicessa e vigilessa: giudice e vigile sono nomi epiceni, per cui è l’articolo che declina il genere: il giudice/la giudice, il vigile/la vigile;
- avvocatessa: avvocata è participio passato, come impiegata (diciamo mai impiegatessa?);
- presidentessa: la presidente/il presidente sono participi presenti;
- poetessa: il poeta, la poeta.
“Il ruolo è neutro, ‘Avvocato’ indica entrambi i generi”
In italiano, attualmente, esistono due generi: maschile e femminile; il neutro non esiste. Si tratta, semmai, del maschile sovraesteso: una scelta linguistica per utilizzare il maschile a indicare entrambi i generi. Eppure, questo non succede per tutte le professioni: nessuno rivendica la neutralità quando si parla di cassiere, infermiere, maestro.
Perché questo neutro non è una regola che vale per tutto, ma solo per alcune parole?
È importante riflettere sul significato. Si accetta facilmente il termine maestra, ma ministra no… oppure i termini impiegata, infermiera, portiera – ma non nell’ambito dello sport, attenzione – perché sono professioni di cura. La professione di cura e di dedica all’altro sono quelle in cui le donne sono sempre state relegate. L’ostilità si verifica in contesti in cui la professione femminile è recente. Si rimane ostili al termine avvocata, in quanto fino al 1919 le donne non potevano svolgere la professione. E figuriamoci se accettiamo una calciatrice portiera, quando – si sa – il calcio è uno sport maschile.

“Sono altri i problemi delle donne…”
Un’ultima considerazione è legata al commento “non sono queste le cose per cui lottare, sono altri i problemi”. Non serve dilungarsi molto sul fatto che:
a) Chi decide per cosa si deve lottare? Su cosa è necessario focalizzarsi? Quali sono i problemi delle donne?
b) La lingua è creatrice: gli oggetti, le professioni, li creiamo noi. Noi parlanti, dando un nome ad un oggetto, lo facciamo esistere. I termini delineano i contesti socio-culturali e l’utilizzo della lingua italiana per quanto riguarda le professioni è fondamentale per creare una cultura di parità di genere nei ruoli.
c) Possiamo lottare su più campi contemporaneamente: capire l’importanza della terminologia utilizzata quotidianamente non corrisponde ad escludere la lotta per la parità salariale, o contro la violenza maschile e di genere; significa portare avanti più istanze in modo parallelo.
[1] V. Gheno, Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole, Einaudi, Torino, 2021, p. 99.
[2] L’assonanza è simile fra i termini tra parentesi e quelli fuori, ma i primi sono quelli che non si riesce proprio ad accettare.
Dottoressa in Giurisprudenza, abilitata alla professione forense, con un Master in Studi e Politiche di Genere. È un'attivista digitale, crea contenuti legali per Chayn Italia, una piattaforma che si occupa di contrastare la violenza di genere utilizzando strumenti digitali, ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive su attualità, diritti umani, privacy e digitale, inclusione, gender gap, violenza di genere.
Attualmente lavora nel settore dell'editoria libraria.