Nel 2014, da uno studio di Cyber Civil Rights, emerge che le donne rappresentano il 90% delle persone che vivono la diffusione non consensuale di immagini intime. Nel 2020, il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno ha analizzato l’andamento di alcuni reati tra cui quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612-ter c.p. e dai risultati riportati nel Report “Violenza contro le donne. Un anno di Codice Rosso”, presentato nel 2020, si evince che, per quanto riguarda chi vive la violenza della diffusione non consensuale, il 18% è di genere maschile contro l’82% di genere femminile.
Uscendo dal binarismo di genere, da uno studio presentato dal CiPHR (Center for Innovate Public Health Research) nel 2016, si deduce che tra gli utenti che si identificano come parte della comunità LGBTIQ+, circa il 15% ha dichiarato di essere stato minacciato di condivisione di materiale intimo, comparato con un 2% della comunità eterosessuale.
La diffusione non consensuale di immagini intime – erroneamente chiamata “revenge porn”[1] – è una violenza di genere, prettamente digitale. Infatti, al giorno d’oggi, più che mai, Internet e i social media invadono la nostra quotidianità e il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime sta dilagando sempre di più all’interno delle piattaforme digitali.
A spiegare molto bene il fenomeno la recente serie televisiva “Privacy”, disponibile su Netflix. Protagoniste sei donne, le cui vite sono stravolte e influenzate dalla violenza di genere e dai giudizi altrui. Intimità, privacy, sessualità e cultura del consenso sono i punti centrali dell’analisi, insieme alla vittimizzazione secondaria. E tutto ciò viene narrato dal female gaze[2].

La diffusione non consensuale di immagini intime è un reato, ma, purtroppo, non offre una tutela giuridica esaustiva. Probabilmente, fra le varie cause, quella legata alla necessità, per il legislatore, di procedere in modo urgente, sia per il movimento dell’opinione pubblica, sia per i diversi fatti di cronaca indici di un aumento continuo e importante della violenza di genere, soprattutto a seguito della violenza vissuta dalla deputata Giulia Sarti[3].
L’art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” è stato introdotto dalla Legge del 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso):
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
L’intera disposizione normativa e i relativi problemi di chiarezza e interpretazione sono stati già analizzati in una mia precedente pubblicazione.
Ma, un aspetto importante, che non tutti conoscono, è che anche solo entrare intenzionalmente in gruppi di “revenge porn” costituisce reato. Nello specifico, con L. n. 238/2021, è stato introdotto, all’art. 600-quater c.p., rubricato “Detenzione o accesso a materiale pornografico”, il delitto di accesso intenzionale a materiale pedopornografico:
“Chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.
Ebbene, i famosi gruppi Telegram[4], contenenti immagini o video a contenuto sessualmente esplicito diffuso senza il consenso delle persone interessate, generalmente contengono moltissimo materiale pedopornografico, ossia relativo a minori di anni diciotto. Non esistendo una suddivisione dei gruppi in base all’età delle persone ritratte nelle immagini, commette reato chi accede a tali gruppi intenzionalmente, ossia conoscendo lo scopo specifico degli stessi e senza giustificato motivo (ad esempio, si avrebbe giustificato motivo qualora si entrasse in un gruppo Telegram per verificare se circolano in rete proprie immagini intime).

Ma come si spiega il fenomeno?
La diffusione non consensuale di immagini intime è una forma di violenza patriarcale, che si manifesta con l’oggettivizzazione del corpo femminile, ossia l’insieme delle pratiche che riducono il soggetto femminile a un oggetto di cui poter disporre a piacimento ed il suo fondamento è la de-umanizzazione:
“processo cognitivo attraverso cui si nega l’umanità a singoli individui o gruppi sociali che si percepiscono come altri rispetto a sé. Deumanizzare, e quindi convincersi che l’altro sia inferiore e non dotato delle stesse nostre qualità intellettive e morali, è fondamentale per legittimare e giustificare violenze che altrimenti apparrebbero per quello che sono: inaccettabili. Le forme di deumanizzazione sono diverse, e quella che riguarda le donne è l’oggettivazione sessuale”.
C. Capria, Campo di battaglia. Le lotte dei corpi femminili, Effequ, Milano, 2021, p. 97-98.
È chiaro come, in relazione alla sessualità, nella nostra società vi sia un doppio standard di valutazione: la sessualità maschile risulta potente, libera e ammirata; quella femminile è giudicata, sottomessa, desoggettivizzata, se non indirizzata meramente alla riproduzione.
Vi siete mai fermati a pensare come la società patriarcale decida sulle modalità di utilizzo e manifestazione dei corpi delle donne? Ebbene, lo fa delineando gli obiettivi e i contesti in cui questi possono apparire pubblicamente, come per la soddisfazione sessuale dello spettatore (es. pornografia mainstream) o per la funzione riproduttiva e la cura (es: allattamento).
Quindi, nel momento in cui una donna esprime liberamente la propria sessualità, rivendicando il piacere sessuale femminile e la libertà di esprimere il proprio corpo – senza alcun legame con il piacere dell’altro o con la strumentale funzione riproduttiva – la conseguenza è la negazione da parte della società di tale autodeterminazione. E tale negazione violenta, tra le varie modalità, viene attuata anche mediante la diffusione non consensuale. In questo modo, la società ci dice “voi non potete essere libere di disporre del vostro corpo”.
A questo punto, le conseguenze su chi vive tale violenza possono essere molto gravi.
Innanzitutto, si potrebbe limitare la propria autodeterminazione, avendo difficoltà nel vivere liberamente la sessualità, con rischio di mitigare o evitare quelle attività che la riguardano, per paura di vivere la condivisione non consensuale e la vittimizzazione secondaria; ancora, potrebbe aversi il c.d. under reporting, ossia l’inibizione delle donne a denunciare le violenze, per paura di non essere credute, protette e di essere colpevolizzate.
Altra possibile conseguenza è il mutamento degli aspetti della propria vita per cercare di porre fine alle persecuzioni: nella sfera online, allontanandosi dalla tecnologia, cambiando utenze o cancellando il profilo dai social media; oppure nella vita “offline”, cambiando residenza o lavoro. Senza dimenticare che, spesso, la conseguenza di una diffusione non consensuale è il licenziamento della persona che l’ha vissuta.
Poi, gravi conseguenze sono quelle psicologiche: nella ricerca pubblicata da Cyber Civil Rights Initiative, nel 2014, emerge che il 93% delle persone che hanno vissuto tale violenza ha dichiarato di aver sofferto di un notevole stress emotivo e il 51% di aver avuto pensieri suicidi.
Tali condizioni psicologiche sono spesso alimentate da alcuni fenomeni: doxing, cioè la condivisione non consensuale di informazioni private e personali (es: recapito telefonico, indirizzo di residenza, profili social); sextortion (minaccia, estorsione); slut shaming (critica per scelte relative alla sfera sessuale); e victim blaming (spostamento della colpa e della sanzione morale e sociale nei confronti della persona offesa).
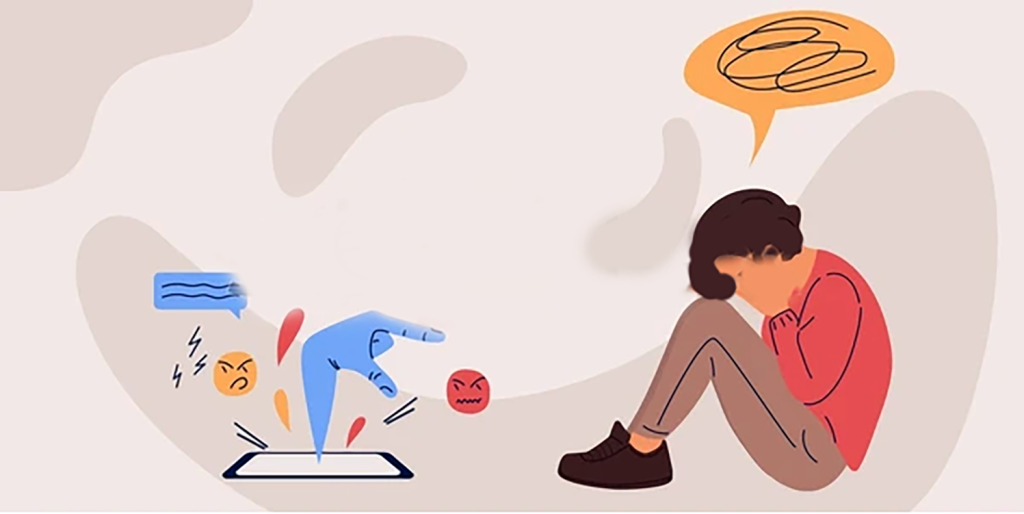
Condividere immagini intime di una persona, senza il suo consenso, è una violenza. Si invade la sfera intima e privata, si lede la fiducia di quella persona. Si priva quella persona del suo diritto di autodeterminazione, decidendo se, come, quando e dove diffondere quelle immagini. Si decide sul suo corpo!
È ovvio che occorrerebbe – anche urgentemente, vista la sempre più ampia diffusione del fenomeno – un intervento legislativo di modifica che possa introdurre una fattispecie incriminatrice in grado di tutelare, in modo maggiormente esaustivo e soprattutto ragionato, tale fenomeno, per dare conto della grave portata di una tale violenza.
Purtroppo, non pare che le Istituzioni abbiano premura di procedere. Infatti, né il Governo italiano interviene per modificare una disposizione che risulta incompleta, poco chiara e per niente esaustiva; né l’Europa interviene con una disciplina unitaria.
Ma è chiaro che una legge non basta. Al di là di qualsiasi intervento legislativo, bisognerebbe soffermarsi sulla matrice di questo fenomeno e sradicare e decostruire l’oggettivizzazione dei corpi delle donne. È necessario approfondire il fenomeno a livello socioculturale, lavorare in un’ottica di dialogo e di comunicazione in relazione alla sessualità e alla cultura del consenso. È davvero fondamentale riconoscere la diffusione non consensuale di immagini intime come violenza di genere. Non normalizzarla, né giustificarla.
Infine, è importante ricordare che in caso di diffusione non consensuale di immagini intime, si può effettuare una segnalazione all’interno del social media, online presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, o ancora online presso la Polizia Postale. Resta, poi, di fondamentale importanza la mappatura dei Centri Anti Violenza ai quali poter chiedere aiuto e sostegno.
[1] Come spiegato in un mio precedente articolo disponibile al link: https://www.ilcontroverso.it/2022/08/19/perche-non-chiamarlo-revenge-porn/
[2] Letteralmente “sguardo femminile”. Indica una teoria cinematografica femminista che rappresenta, appunto, lo sguardo della donna spettatrice e le donne come soggetti dotati di agency.
[3] Come scrive G. M. Caletti in “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612- ter c.p.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?, sull’iter processuale “ha influito – inutile nasconderselo – la vicenda di Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, le cui immagini intime, dopo alcuni anni di oblio, sono tornate alla ribalta della “viralità” in occasione dello scandalo politico che l’ha colpita. La Commissione Giustizia del Senato era sul punto di avviare i lavori su tre proposte di legge in argomento, alle quali stava per aggiungersene una quarta alla Camera. Queste peraltro non si limitavano alla mera previsione di un nuovo reato, ma si proponevano di predisporre un più ampio ventaglio di strumenti (non esclusivamente penali) di contrasto e prevenzione della pornografia non consensuale. Sulla spinta emotiva e mediatica del caso “Sarti”, invece, il Parlamento ha “bruciato le tappe”, privilegiando l’immediata incriminazione specifica domandata a gran voce dall’opinione pubblica”.
[4] A proposito dei gruppi Telegram, un prezioso lavoro di ricerca è stato svolto da Silvia Semenzin e Lucia Bainotti, nel loro saggio “Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone“. E due sono state le inchieste di Wired Italia sul fenomeno di diffusione non consensuale nei gruppi Telegram, una di Luca Zorloni e l’altra di Simone Fontana.
Dottoressa in Giurisprudenza, abilitata alla professione forense, con un Master in Studi e Politiche di Genere. È un'attivista digitale, crea contenuti legali per Chayn Italia, una piattaforma che si occupa di contrastare la violenza di genere utilizzando strumenti digitali, ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive su attualità, diritti umani, privacy e digitale, inclusione, gender gap, violenza di genere.
Attualmente lavora nel settore dell'editoria libraria.






