Nella nostra società non possiamo fare a meno della competizione in ogni ambito: dallo sport (giustamente insito nella sua natura), alla scuola, al lavoro e a qualsiasi passione o hobby che pratichiamo. Ci sentiamo sempre in dovere di confrontarci con gli altri, di essere migliori di qualcun altro e non solo di dare il meglio per noi stessi. E vi dirò di più, non è neanche colpa nostra, perché non la scegliamo noi questa competitività: ce l’hanno insegnata, o meglio, inculcata. Sì, perché la società in cui viviamo in questa era, quella dell’estremo e dannato consumismo e materialismo, già da piccoli a scuola, ci mostrava che sono i numeri quelli che contano. La derivazione di questo tipo di mentalità è da attribuire perciò al nostro sistema educativo: la sua linea guida è infatti quella di prediligere sempre e comunque la prestazione, a discapito della personalità. Pensiamo ai nuovi test ad esempio, quelli che sembrano dei quiz a punti, che valgono addirittura per determinare il percorso di vita di uno studente che si appresta a fare il suo ingresso all’università. Ma questa “tradizione educativa” il nostro sistema non l’ha creata, bensì adottata, in quanto la nostra cultura ha origini, e quindi caratteristiche, ben differenti. Di chi stiamo parlando? Sempre di loro, ovviamente: i Greci. Per la cultura ellenica, nell’educazione era fondamentale la condizione pulsionale, si portava alla luce il livello e la risonanza emotiva dei comportamenti. Platone diceva che “la testa non si apre se prima non si apre il cuore”. Necessario dunque diventa per gli educatori saper trasmettere a livello comunicativo, oltre al sapere, anche la passione e quindi l’emozione per una determinata disciplina. Ricordate qualche insegnante capace in questo senso? Io si, in sedici anni di formazione scolastica si contano sulle dita di una mano. I sentimenti invece nell’antica Grecia si imparavano: l’esempio classico è proprio l’Olimpo. Qui ad ogni ruolo corrisponde un sentimento e una capacità specifica di un dio: il solare e vincente Apollo dio del sole e della luce, la sensuale, passionale e creativa Afrodite dea dell’amore e della bellezza, il contraddittorio e irruento Dioniso dio del vino e dell’estasi eccetera eccetera. Tra gli altri, l’icona nel nostro caso è quella di Prometeo, titano che ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini e subisce la punizione di Zeus che lo incatena a una rupe ai confini del mondo e poi lo fa sprofondare. Il significato è celato proprio in quello che viviamo nella nostra contemporaneità: il Prometeo incatenato rappresenta il concetto di limite che è stato superato, in quanto la tecnica non può e non deve superare le leggi della natura. Per comprendere meglio e riflettere il concetto nel nostro mondo, provate a sostituire la natura con la nostra soggettività o la nostra personalità e la tecnica proprio con quel sistema che prevede e pretende dai soggetti un’oggettività di comprensione comune in tutti i campi, ovvero proprio una tecnica esasperata e tradotta in numeri finali, che poi vanno a formare quella competitività di cui parlavamo: la frittata è fatta.
Ma se la tradizione da cui proveniamo è di diversa natura rispetto al nostro attuale sistema educativo, da chi lo abbiamo adottato? Anche qui la risposta è abbastanza deducibile: dalla cultura anglosassone. Abbiamo dunque scelto la pragmaticità degli inglesi che storicamente ma addirittura linguisticamente, non possiedono il concetto di astrazione. Tanto per rendere l’idea, prendiamo ad esempio la parola “somebody” che traduciamo con “qualcuno”: composta da some (qualche) e body (corpo). Ovvero, la concretezza del corpo viene utilizzata dall’inglese per indicare una parola che può anche non avere una connotazione precisa. Seppur da un’estrema e breve sintesi, otteniamo così una deduzione che fa riflettere su tutta la concezione inglese: la precisa funzione della praticità. Guardiamo la lingua italiana invece, così imprecisa, letteraria e approssimativa, fatta da costanti sostantivi, aggettivi e avverbi in ogni frase, migliaia di sinonimi per ogni campo semantico: ecco la differenza abissale di due lingue (“che scoperta” direte voi) ma anche di un modo opposto, tradizionalmente, di concepire e dunque giudicare. Giudicare perché con un sistema che non è nostro, privo di astrazione, basato sulla materia dei voti e quindi dei numeri, ci siamo completamente dimenticati di valutare la soggettività di ognuno, valutando solo la comprensione di un testo scritto, facendo valere solo la prestazione. Eccola la differenza: questo non è più educare, questo è istruire. Adottando noi un sistema diametralmente opposto a quello che sarebbe stato compatibile, stiamo solo forzando una serratura con la chiave sbagliata.
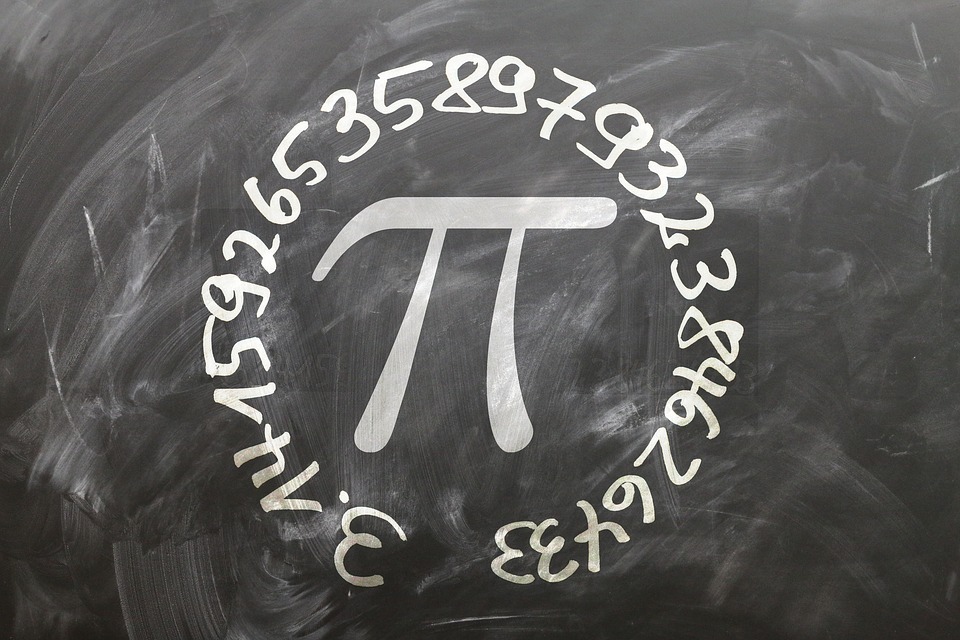
È da qui allora che nasce la competizione sociale moderna? Forse non tutta, ma buona parte molto probabilmente. Se avessimo perseguito la strada indicata dalla filosofia greca, forse non ne starei scrivendo adesso. Forse però non saremmo arrivati neanche al consumismo e al capitalismo, che a braccetto con la competizione ci condiziona così. Non avremmo avuto così tanto la necessità di generare bisogni e poi prodotti che li soddisfino, di portare le cose al nulla nel più breve tempo possibile. Al contrario, ognuno avrebbe agito con “fronéin”, il buon senso dell’essere saggi, del capire cosa è meglio e cosa è peggio, del fare la scelta giusta. Ognuno avrebbe pensato alla propria eudaimonìa, ovvero la buona riuscita del proprio “demone”, della propria vocazione, che i greci traducono con una semplice parola: felicità. Ognuno in questo modo, forse, avrebbe imparato un po’ di più a conoscere se stesso (γνῶθι σεαυτόν).
Ma con i “se” e con i “forse”, si sa, non si scrive la storia. La storia ci pone ora nelle condizioni di continuare a cercare di fare sempre più degli altri, di essere in continuo aggiornamento. E allora la domanda con cui ci lasciamo è questa: siamo ancora capaci di rendere utile nella nostra vita tutto quello che produciamo?
A noi, adesso, l’ardua sentenza.



